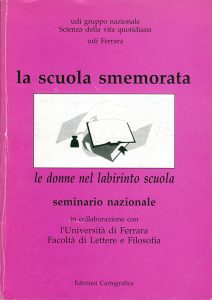
Introduzione agli atti
Ci piace dedicare ogni nostra iniziativa a una donna e pensando di entrare nel solenne labirinto di una scuola smemorata di noi, dei nostri corpi, della vita quotidiana e molteplice ci sembra che il “lessico famigliare” di Natalia Ginzburg sia una buona guida da portare in cartella.
“Esili barlumi e schegge di quanto abbiamo visto e udito” dice Natalia delle sue parole, eppure poi ricorda che “…quelle frasi sono il nostro latino, il vocabolario dei nostri giorni andati,… la testimonianza di un nucleo vitale che ha cessato di esistere ma che sopravvive nei suoi testi, salvati dalla furia delle acque, dalla corrosione del tempo.”
Non ha parlato Natalia dai luoghi del femminismo e neppure ha ascritto al genere la sua lingua ma pure il ritmo lieve e tenace dei suoi scritti ricorda a ogni donna che non è possibile dirsi e dire senza una qualche lingua che ci renda comprensibili a noi stesse, che ci consenta di raccontare e raccontarci, che ci restituisca i luoghi di una memoria in cui gesti e sogni, parole e desideri, fatiche e scelte, hanno lasciato tracce materiali di quel sentimento del reale che ad ognuna di noi appartiene.
La sua presenza può ricordare a noi in questi giorni che ciò che proponiamo è una ricerca non una teoria, un luogo d’incontro non una scuola, un percorso non un traguardo e che il sapere non è l’accumulo ordinato di nozioni “disciplinari” ma lo stratificarsi d’incontri, emozioni, parole e sogni che la vita deposita dentro di noi, un patrimonio che si può trasmettere con generosità, non per verità.
TRA CONTENITORE E CONTENUTI: OGGETTI SMARRITI NELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE (Rosangela Pesenti, insegnante, Bergamo)
Prima di entrare nel merito del misterioso tema che mi sono assegnata vorrei raccontare la genesi e un po’ l’ambizione di questo seminario.
Nato dalla voglia di affrontare il nodo del lavoro della riproduzione in uno dei luoghi, la scuola, socialmente più significativi, ha voluto proporsi come crocevia di esperienze molteplici e diversificate sul piano culturale, ma anche come “contenitore” che, nel suo ritmo materiale (l’organizzazione concreta delle giornate), renda visibile quel diverso muoversi e riconoscersi dei corpi, che è sempre proprio dei luoghi e delle esperienze delle donne.
Il tempo necessariamente anche qui, come nella scuola, è già tutto finalizzato, in quella tradizionale divisione dei ruoli che ci situa di qua o di là del tavolo amplificando alcune possibilità di parola e “costringendo” tutte noi in un ascolto poco segnato dalla reciprocità.
Ma si tratta di una necessità di cui avvertiamo il limite e i lavori di gruppo, certo insufficienti per una reale moltiplicazione della parola, vorremmo che avessero quella dimensione quotidiana dello scambio non necessariamente finalizzato, più segnato dai percorsi singolari delle fantasie, dei desideri, delle esperienze, delle domande di ognuna che dalle strettoie di un approfondimento rigidamente disciplinare che renderebbe il tempo insufficiente e vano.
Voglio dire che assumiamo il limite nella sua dimensione vitale e anche gioiosa che ci richiede altri momenti e altri appuntamenti, che ci restituisce un tempo fruibile per la riflessione nelle modalità che ognuna sente più vicine a sé, in gruppo quindi, o anche sole nelle strade di questa splendida città.
Vorrei che non ci sentissimo “oggetti smarriti” ma conservassimo quella curiosità reciproca che ci ha portate qui, come dimensione di una possibilità che perfino nelle scansioni più programmate ci consente percorsi inediti e felici sorprese.
Dovendo parlare della scuola media superiore non riuscivo a evadere dallo spazio anonimo che la mia scuola mi presenta ogni anno il primo giorno.
Spazio anonimo in cui gli oggetti sembrano smarriti, sembrano cioè aver perso il senso, un significato fruibile, l’appartenenza a qualcuno o qualcosa.
Ho scoperto una volta che sui treni, nelle stazioni, si perdono gli oggetti più incredibili, non solo quelli più ovvi, ombrelli, borse, ma altri così indispensabili da lasciare spazio ad ogni immaginazione.
Questi oggetti restano lì, in attesa del proprietario o dell’asta, assolutamente deprivati di senso, utilizzabili per altre storie, malleabili perfino da altri significati.
Nello spazio anonimo e vuoto della mia scuola il primo settembre i banchi sono i primi oggetti che si avvicinano allo sguardo: apparentemente uguali sono in realtà vistosamente segnati.
Tracce incise con forza, forse per noia o rabbia repressa o felicità, segni aggressivi che gli adulti deplorano con severità perché segnalano un tempo misterioso e incontrollabile in cui ragazzi e ragazze si sottraggono all’ordine dei gesti imposti, si sottraggono al loro ruolo “oggettuale”, opponendo la propria soggettività in un messaggio che rifiuta violentemente il nostro codice di comunicazione.
Ad un ambiente, imposto dagli adulti nel suo ordine e nei suoi significati, oppongono una sorta di passività ostile che si scatena in una piccola, feroce distruzione degli oggetti d’uso.
Deturpare i banchi come, in seguito, i muri e i monumenti in una rabbia che segnala la totale “ignoranza” delle categorie in cui praticare una memoria di sé come possibilità di lasciare davvero i propri segni nel mondo: il rifiuto delle parole di una trasmissione culturale che evidentemente s’inscrive in loro nei codici gestuali che ne rivelano l’ambiguità e l’intima violenza.
Ancora più ambigui, infatti, se guardati nella loro dimensione materiale, risultano i libri.
Oggetto di interminabili discussioni che ne sezionano i contenuti nella ricerca di una fruibilità che risponda agli infiniti criteri dell’apprendimento, conoscono una loro piatta uniformità nelle leggi fisiche del peso e del volume e in quelle economiche del mercato.
Il loro messaggio, sul quale ci s’intestardisce in dispute al limite dell’ideologia, è banalmente simile all’occhio dello studente che ne controlla il numero delle pagine e la fatica dello zaino.
Monumenti ingombranti della cultura, la maggior parte dei libri scolastici sono assolutamente inagibili in un quotidiano piacere, anche quando si propongono come obiettivo l’interesse e la curiosità per la lettura.
Gli oggetti, pur nel loro inerte e inoffensivo mutismo, riducono i corpi delle ragazze e dei ragazzi ad un ordine che, se appare palesemente assurdo nell’analisi dei singoli segmenti di comportamento, nell’insieme segnala un’idea di trasmissione che ancora appiattisce gli allievi nella tabula rasa.
Stare in fila nei banchi senza parlare, alzare la mano per chiedere di andare in bagno, mentire sui propri bisogni, uscire nel breve spazio dell’intervallo, conservare lo stesso atteggiamento per cinque ore: un modo di vivere che è l’esatto contrario di quell’autonomia che fuori è loro richiesta in una gestione spesso non solo della propria vita ma anche in una co-gestione della casa che rende, soprattutto le ragazze, pienamente adulte.
Uno spazio quindi in cui è censurato e deplorato tutto ciò che appartiene alla vita normale, il piacere di chiacchierare, il muoversi liberamente, il piacere di imparare scegliendo da sé fatica e impegno, le emozioni diverse che attraversano il tempo e ne scandiscono i ritmi più autentici.
Che cosa si impara a scuola?
“Tutto quello che non serve per vivere” ha risposto un mio alunno, intuendo anche quell’astrattezza delle discipline che appaiono noiose e faticose proprio perché apprese al di fuori della propria storia, del reale muoversi del proprio corpo nel mondo.
Raramente infatti i risultati scolastici corrispondono alle inclinazioni che poi prenderà la vita.
La rimozione del corpo, attenuata dalle varie riforme negli altri ordini di scuola, è macroscopicamente visibile nella scuola media superiore proprio nel momento in cui l’assunzione piena dell’identità di uomo e di donna si prepara a tradursi in scelte che segneranno tutta la vita.
L’amore, la relazione con l’altro sesso e la conoscenza del proprio, la scelta del lavoro, del proprio ruolo dentro la dinamica familiare e amicale, l’esercizio dei diritti di cittadinanza e del voto prima di tutto, che esercitato a diciotto anni è un evento che si colloca spesso nel tempo stesso della scuola: nessun alfabeto viene proposto per imparare a districare sentimenti e scelte, quel mondo nuovo e tangibile nell’immediata prossimità dei corpi dal quale le materie scolastiche sembrano spesso lontane anni luce.
Se nella gestione del corpo inerme, come lo definisce Lidia, dei bambini, portiamo nella scuola, anche se in forma inconsapevole, non elaborata, quei saperi del quotidiano con cui abbiamo dimestichezza nella vita privata, non sappiamo rapportarci con un corpo adolescente che rispecchia il nostro per dimensioni e ci si oppone con i tratti di una storia che ci è sconosciuta.
Lo riduciamo così a una dimensione manipolabile che non conosce le tenerezze dell’accudimento ma la rigidità delle regole con cui lo costringiamo in uno spazio meno inquietante per noi.
Così emerge il disagio come parola strozzata che si trasforma in negazione, di sé, degli altri, di ciò che non si riesce a comprendere o a vivere perché ne sono state censurate le strade.
Organizzata secondo un modello funzionale al lavoro di produzione degli oggetti, la scuola riduce ad una marginalità ininfluente anche gli alfabeti che pure nel quotidiano sappiamo parlare con competenza, in uno scambio continuo tra corpi, gesti e pensieri.
Il tempo, interamente programmato a prescindere dai soggetti che ne potrebbero pattuire utilmente la scansione in un’assunzione di responsabilità che sarebbe insieme pratica educativa e gestione più efficiente ed efficace, finisce col frantumarsi in un’emergenza che si chiama genericamente “disagio”.
E questo disagio, censurato nelle storie concrete che la scuola tende ad ignorare, precipita sulle nostre teste nella forma di allarmate circolari in cui finalmente si parla della necessità di “star bene” come vissuto preventivo di fenomeni ormai socialmente eclatanti.
Al di là di tutte le buone intenzioni ci precipita addosso l’ansiosa fantasia di poter mutare il mondo con le parole senza modificare i percorsi materiali che segmentano e censurano i corpi e le storie.
Va ripensato il modello della trasmissione e ripensato a partire da noi, uomini e donne adulti che si rivolgono alle nuove generazioni, maschi e femmine che vivono in quel loro mondo che si chiama ambiente con la loro identità sessuata.
Avendo confinato il lavoro della riproduzione in quel privato casalingo di cui viene occultata la trasmissione, nella scuola non ci si interroga sulle coordinate materiali che sostengono di fatto la costruzione dell’identità e il suo agire concreto nel mondo nella scelta di un mestiere o di un altro, di un tipo di studi o di un altro, di un modo di esprimersi, di vestirsi, di innamorarsi.
La categoria di genere, mai citata nelle circolari relative al disagio e all’educazione alla salute, risulta imprescindibile se guardiamo i ragazzi e le ragazze reali delle nostre classi.
Tra maschi e femmine i comportamenti si divaricano, confermati dai dati che raggruppano i due generi in percentuali diverse nei vari fenomeni con cui siamo costrette a misurarci: tossicodipen-denza per i maschi e anoressia per le femmine e un immaginario così diverso sull’AIDS da rendere vana quando non rischiosa qualsiasi campagna per la prevenzione svolta sotto un segno neutro.
In quasi tutte le classi un piccolo gruppo di maschi rifiuta lo studio e si attesta su comportamenti vistosamente provocatori, le femmine sono più brave e il comportamento più tranquillo ci esonera dall’interrogarci sui moduli linguistici che usiamo per definirle, pesantemente segnati da un immaginario che veicola stereotipi perfino al di là delle nostre intenzioni.
Ad un corso sulla prevenzione dell’AIDS un docente spiegava il rifiuto della scuola, da parte di una fetta di giovani maschi, con la paura di confrontarsi con il padre, identificato con il libro che propone con la sua mole un’impari competizione sul piano del sapere.
Credo che ogni spiegazione in questo momento possa rappresentare almeno una volontà “buona” di affrontare i problemi, questa però mi convince poco.
Ho la sensazione invece che il problema abbia tali aspetti di novità da richiederci uno sforzo maggiore di attenzione e di fantasia e la capacità di interrogarci su molte delle categorie con le quali ci siamo abituati a leggere il mondo e noi stessi.
Se resto sul piano dei dati posso rilevare che questa è la prima generazione di maschi che ha condiviso fin dall’infanzia uno spazio “paritario” con le femmine.
Una condivisione di spazi che ha “neutralizzato” le pur evidenti differenze (e non solo biologiche) rendendogliele illeggibili e spesso perfino innominabili.
Una doppia deprivazione che ha agito diversamente su due storie che comunque erano vistosamente diverse.
Perché nessuno di noi prescinde dalle immagini in cui impara a riconoscersi come genere fin dalla nascita (da quel nastro rosa o azzurro che segnala il sesso prima ancora del nome).
La stessa offerta formativa pubblica interamente condivisa (almeno fino ad una certa età) dentro un modello che veicola il primato maschile, in un sapere forzatamente neutro, non poteva avere lo stesso effetto sui maschi e sulle femmine (com’è del resto per altre differenze).
Nelle loro diverse storie sono comunque segnati la certezza di un diritto atavico o la novità di una conquista da “meritare” fino in fondo, di uno spazio aperto per la prima volta nella storia da occupare senza interrogarsi molto.
Nello spazio tradizionale dell’aula anche se nella divaricazione dei comportamenti tra rissoso rifiuto e passivo adattamento la coincidenza di genere non è assoluta, le categorie di lettura del disagio ripercorrono gli stereotipi più tradizionali della maggiore vivacità maschile e della maggior acquiescenza femminile, come se fossero la declinazione comportamentale di un innegabile dato biologico.
Se lo spazio però viene restituito ad una praticabilità più consona ai bisogni e le regole ricondotte a quella normale buona educazione che, consentendo ad ognuno di uscire quando ha bisogno e di mangiare quando ha fame, assegna il lavoro collettivo alla responsabilità della scelta, le differenze diventano più visibili.
Tutte le differenze e prima di tutto quella fra ragazzi e ragazze: restituiti alla responsabilità di sé a partire dal gesto più semplice della propria collocazione nello spazio, i primi appaiono refrattari ad assumere la responsabilità dell’aula che va ogni volta disposta in modo funzionale al lavoro, più per incapacità dei gesti che per cattiva volontà di collaborazione, e restano un po’ aggrappati al proprio banco e alla propria sedia fino a che ognuno trova lo spazio più congeniale nella dinamica dei rapporti così come nella disposizione dello spazio.
Emerge allora con chiarezza il segno femminile di un maternage che le ragazze praticano nel minuto, naturale accudimento con cui sistemano e risistemano cose e persone secondo tracciati personali anche invadenti ma per i quali possiedono una sorta di “naturale” capacità.
Quell’autonomia personale che non si insegna a scuola (perché non si impara sui libri), ma che viene precocemente richiesta alle bambine, si traduce in questo sapere che chiamo maternage, intendendo con questo termine la tradizionale capacità femminile di mettere insieme risorse e relazioni dentro i vincoli stabiliti trasgredendoli quel tanto che serve a far funzionare le cose ma senza mai mettere in discussione l’impianto che ha costruito quei vincoli.
In uno spazio in cui i loro corpi possono liberamente muoversi assumendo con consapevolezza anche i vincoli, che nessuno di noi ha la concreta possibilità di rompere, sono più visibili le storie che, pur nella variabile delle singolarità, segnalano chiaramente l’appartenenza di genere e vistosamente proprio nell’emergere dei disagi.
Non è uno spazio semplice da attraversare insieme, l’aula, se il sapere è un “movimento verso…” che ci coinvolge intere e interi.
Non è facile per me rendere visibile un corpo di donna in una professione in cui proprio la femminilizzazione complica i piani giocando le identità tra due estremi ugualmente negativi: da un lato l’impegno puntiglioso e pedante in una “produttività” che si esplica nell’assunzione dei più rigidi stereotipi del neutro maschile, dall’altro l’accomodamento negli aspetti più deteriori, di un maternage appunto, che ripete la lezione imparata (a scuola) devolvendo le proprie energie a mezzadria tra una casa e una luogo di lavoro in cui vengono assunti e riprodotti i significati più subalterni e ambigui del genere femminile.
E nella maggior parte dei casi, nella scuola superiore, un rifiuto violento di quegli aspetti dell’accudimento materno che, devoluti magari in forma eccessiva e soffocante ai propri figli, vengono considerati diseducativi anche in quelle banali forme di comprensione e tolleranza che tutta la specie dovrebbe assumere nei confronti dei propri “cuccioli”.
Ragazze e ragazzi vengono consegnati ad una freddezza sospettosa che si pretende giustificata dalle dimensioni dei corpi e dalle immagini di cui si vestono, nell’assunzione totalizzante e maldestra di tutti gli stereotipi che il mondo adulto propone.
Io arrivo in classe con un corpo di donna e con la mia storia, coi suoi significati assunti nei sentimenti personali così come in quelle emozioni collettive scelte o incontrate per caso nei crocevia che la storia mette sul nostro cammino.
Una strada difficile da percorrere, in quei segmenti rigidi che sono le ore scolastiche, anche per una consapevole assunzione di parzialità che non è soltanto la feconda consapevolezza del mio essere diventata adulta, ma il sentimento di un’asimmetria inevitabile nel mio rivolgermi agli allievi e alle allieve.
E non mi riferisco a scelte didattiche o a distanze affettive ma proprio a quella singolarità che i corpi segnalano nel modo stesso in cui le responsabilità o le professioni, sottratte alla rigidità dei ruoli, vengono agite.
E tanto più in un professione che ha per “oggetto” la trasmissione del sapere.
Nel mio sottrarmi alle connotazioni neutre del ruolo rendendo visibili le responsabilità e le competenze anche nei loro limiti, inadeguatezze, ambiguità, sottraggo il mio essere donna alle curiosità clandestine per esporlo intero nella pratica di un punto di vista situato.
Non si tratta di una dichiarazione verbale ma del mio stesso muovermi nelle discipline come nell’aula, che non si traduce in richieste di riflessione che riterrei indiscrete, funzionando semplicemente da cartina al tornasole per i loro corpi, che magari tranquillamente vissuti nello stereotipo del proprio genere grazie alla copertura del neutro, si presentano più incerti e impastati di interrogativi, e quindi più vulnerabili, nella scoperta della inevitabile, originaria, differenza di sesso.
Le diffidenze nei miei confronti, inevitabili nel contesto in cui abito, per una storia privata e politica che ha trasgredito molti dei percorsi comuni, vengono cancellate, più o meno consapevolmente, nell’agio che io cerco faticosamente di conservare nell’aula e che a loro sembra finalmente una normale serenità.
Ho dovuto anch’io imparare a ridere e sorridere in uno spazio che all’inizio mi ha catturata nei gesti previsti, perfino contro la mia volontà, restituire al lavoro un suo faticoso piacere togliendo alle verifiche l’atmosfera enfatica e terrorizzante di “prova della Verità” che autorizza qualsiasi sotterfugio come legittima difesa.
Fuori dal posto stabilito i corpi sembrano davvero disarmati e non è facile conservare le condizioni perché restino tali senza timore di indebite aggressioni.
I maschi che posseggono già i codici culturali previsti, dopo la titubanza iniziale, trovano una loro strada in cui fruire utilmente della mia presenza per cercare una storia nuova in cui operare le proprie scelte, anche separandosi dai più antichi e sedimentati gesti dell’appartenenza di genere e cominciano a provarsi nei rapporti tra loro e con l’altro sesso pensando ciò che sono e ciò che vogliono essere.
Io cerco di insegnare che la storia è oggetto di indagine ma anche luogo delle nostre scelte, ricerca di una consapevolezza che non è mai dato acquisito una volta per tutte.
Il gruppo dei maschi che più corrisponde a quei “soggetti a rischio” descritti nelle circolari, che tende a vivere ai margini, chiuso in comportamenti cosiddetti “di disturbo”, rivela appieno la fragilità di un analfabetismo che va ben oltre le competenze della parola.
I codici che conoscono, per classe sociale, storia familiare, singolarità personale, sembrano rappresentare un marchio che li ferma sulla soglia delle nostre aule come ad una invalicabile frontiera.
Eppure anche per loro finisco col rappresentare un possibile passaporto al quale sanno di poter chiedere almeno quel minimo di affettuosità, di simpatia, di giusto ed umano rimprovero che li esonera dalla costante recita di una “durezza” che li ingabbia nel ruolo.
Più semplice, in apparenza, il rapporto con le ragazze, che si sentono libere di giocare con me una complicità femminile di cui stanno cominciando a provare gli alfabeti, mi rimanda in realtà a una complessità che riconosco prima di tutto in me stessa, oscillante tra i rischi del rispecchiamento e la necessità di una distanza che potrebbe essere fraintesa, confondersi con le immagini tradizionali in cui sono collocati i rapporti tra donne di cui non abbiamo ancora elaborato i codici di trasmissione.
Essere adulta conservando una prossimità fisica con le loro domande, elaborare categorie di lettura della nostra storia senza cadere nello schematismo di una reciprocità che si nutre di facili conferme, non aspettare le loro risposte ma essere disponibile ad accoglierle, godere dei loro entusiasmi senza forzare una condivisione inopportuna, essere discreta senza freddezza, dissentire senza censurare…
Un elenco che sembra rigido e vuoto decalogo se non fosse la difficile traduzione verbale di un codice che il mio corpo ha elaborato piano, gesto dopo gesto.
Le ragazze che si accostano con soggezione alle mie parole, attente e curiose ma consapevoli dell’impegno richiesto trovano il modo di dare un tono più lieve e amicale al ritmo serrato che io di fatto impongo a me stessa e a loro nel lavoro scolastico, avvicinando con disinvolta, affettuosa franchezza il mio corpo.
Commentano senza ritegno il mio abbigliamento, le mie stanchezze, le mie distrazioni: – prof si “tiri insieme” se va a Ferrara – mi hanno detto prima di partire, rifacendo il verso ad un modo di dire dialettale che io uso spesso riferendomi alle necessità del mio aspetto fisico, psicologico e professionale insieme.
I loro occhi sono uno specchio implacabile e affettuoso.
L’altro giorno Chiara mi ha detto con aria felice “prof l’ho sognata: aveva un body nero, scollato, i capelli sciolti, stava benissimo.”
Abbiamo riso insieme, a quell’immagine così lontana dai miei “infagottamenti” invernali, ma anche ad un modo di essere, di vivere il corpo, come piacere di sé e dell’altra.
Di fronte alle immagini del corpo femminile, che i media veicolano in modo potente, le ragazze cercano un modo per sottrarsi all’ansia di una perfezione impossibile senza censurare l’espressione della propria identità.
Perché la realizzazione di sé continua ad essere proposta, a queste giovani donne, come una sorta di corollario di un corpo confezionato secondo canoni stilistici che rimandano messaggi ben più ambigui.
Il successo nel lavoro, la competenza professionale sono identificate con un’immagine levigata che ha poco a che vedere con le fatiche delle donne reali.
Come ridare corpi reali ai percorsi di vita nell’impasto complesso di scelte faticose e piacere di sé ?
Come rendere davvero liberi i loro corpi da un modello che, apparentemente disegnato secondo i canoni dell’emancipazione, ripete i più tradizionali stereotipi, contribuendo, io credo, a ingigantire quel disagio del “mutare dimensioni”, che è proprio dell’adolescenza?
Spesso il disagio si esprime in un difficile rapporto col cibo che, rappresentando insieme necessità di sopravvivenza e relazione col mondo, andrebbe indagato non solo dentro un rapporto familiare che, più o meno apertamente incentra le responsabilità sulla figura della madre (come immagine del nutrimento), ma anche nei messaggi culturali del contesto sociale.
Ecco allora che l’abbigliamento diventa chiave di lettura di sé, oggetto di indagine che incrocia necessità e desideri, censure e rimozioni, trasgressione e paura, norma e creatività.
Non a caso i trattati di educazione delle “fanciulle” presentavano una minuziosa attenzione per l’abbigliamento e il senso comune, ancora oggi, tende a leggere nell’abbigliamento femminile una connotazione morale.
Le immagini, lo sappiamo, sono un veicolo importante di trasmissione, soprattutto per quell’intrinseca capacità di depositarsi nei gesti ben al di là della consapevolezza delle parole.
E anche con le immagini dobbiamo fare i conti se vogliamo interrogarci fino in fondo sulla trasmissione tra donne, se non vogliamo rischiare di elaborare categorie intellettuali che, pre-scindendo dal vivere quotidiano, rimangano frutto sterile di una generazione presto cancellata.
Non è un caso che proprio la trasmissione politica tra donne sia la più difficile e si sedimenti facilmente in immagini stereotipe
da cui le nuove generazioni si tengono debitamente a distanza perché sembrano precludere quel felice ingresso nel mondo che giustamente desiderano.
“Io non sono femminista ma…” tengono a precisare le ragazze esorcizzando un’immagine della quale vogliono conservare solo quelle che, ai loro occhi, sono le proposte più sensate e praticabili.
Com’è stato possibile aprire una frattura tra noi e loro costringendo la nostra storia, non ancora “passata”, in semplificazioni che amplificano dati marginali per cancellare la complessità dell’evento che pure ha lasciato un segno non cancellabile su questo secolo ?
Se penso alle immagini di cui si è vestita la nostra generazione di donne mi sembra che i nostri corpi abbiano vissuto una duplice mutazione in corrispondenza di un mutamento interiore che era il movimento stesso verso la ricerca di un’identità in cui riconoscersi e misurarsi.
Per chi si affacciava all’adolescenza nel ’68 i jeans e l’ eskimo erano il simbolo di una scelta, spesso vissuta più nella dimensione emotiva dell’appartenenza a un gruppo che nei difficili distinguo della ragione, ma efficace nel messaggio di liberatorio rifiuto che si offriva a se stessi nella forma di un’opposizione “fisica” al mondo degli adulti.
Per le ragazze la stessa divisa apriva l’esaltante avventura di un percorso egualitario che ti affrancava dall’apprendimento di una femminilità che appariva (e in buona parte lo era) la mortificazione dell’intelligenza: dimenticare quel corpo che richiedeva abitino, tacchi e borsetta, e partire leggere per le avventure dello spirito.
Pochi anni dopo riempivamo le piazze con i colori smaglianti delle nostre gonne a fiori. Scialle, zoccoli, abiti larghi e comodi, confezionati nelle stoffe “naturali” che venivano dall’oriente, (perché in occidente l’orribile sintetico degli anni ’60 le aveva accantonate) o ritrovati in quell’abbigliamento intimo delle nonne che portavamo alla luce del sole come il sottile e felice riscatto di un corpo sessuato che nominavamo per la prima volta.
La collocazione in un orizzonte di senso completamente diverso era evidente nelle nostre parole, nei nostri scritti, nel nostro modo di guardarci, ma trovava una sua immediata visibilità politica proprio in quel nostro modo di vestire i corpi e occupare gli spazi.
Nelle sue “linee generali” era una sorta di unica veste condivisa, ma le varianti personali erano poi infinite come un gioco, che oggi raramente riusciamo a ritrovare con la stessa felicità d’invenzione nelle forme più discrete e sofisticate in cui ci infila la difficile pratica del quotidiano.
Di queste due “rotture” storiche nell’abbigliamento, che divennero poi anche moda (con tutto ciò che sappiamo anche in termini di mercato), quella maschile è rimasta nelle scelte, nei gusti, nelle ribellioni, nelle abitudini degli adolescenti, maschi e femmine, quella femminile ha lasciato qualche “evocazione decorativa” o poco più.
Un fenomeno marginale forse, ma qual’è il ruolo delle immagini nei processi di trasmissione e come veicola il corpo quell’immagine di noi che sembra spesso “pensata” in modo diverso da come è “vissuta”?
Nello “psicologismo” a cui viene troppo spesso ridotto ogni malessere dell’anima a me sembra di ritrovare una qualche dolorosa collocazione politica del corpo.
Nel senso di una propria incerta collocazione nella polis a cominciare dagli ambigui confini di quel diritto di cittadinanza alla cui certezza ed esercizio dovremmo educare ragazze e ragazzi a scuola.
Nel percorso storico, che di volta in volta approfondisco in classe, il difficile enuclearsi del concetto di cittadino si esprime nella norma in un’astrazione che, indagata nel preciso contesto storico, rende evidente la sua connotazione maschile.
E anche oggi, che l’astrazione sembra finalmente un neutro reale che sottende tutta la specie, in realtà risulta solo la faticosa conquista di un punto di partenza per una strada ancora da tracciare.
L’indagine mette in luce la faticosa conquista del diritto di ognuno all’integrità fisica e all’identità personale: sembrano tranquille garanzie raggiunte, ma declinate al maschile e al femminile aprono domande che rivelano tutta la precarietà delle acquisizioni su cui si fonda il presente.
Quel nome ad esempio, che ci registra alla nascita in un’appartenenza sia territoriale e che familiare, fonda molto più che il semplice accesso ai diritti, nel complesso legame che ognuno e ognuna di noi intrattiene proprio col suo doppio nominarsi nel nome e nel cognome.
Sapere che si viene iscritti/e all’anagrafe col cognome del padre non in forza di una legge ma di una consuetudine talmente forte da poter sostenere l’intero minuzioso castello di tutte le “carte” apre la possibilità di un doppio percorso, nel passato e nel futuro, che ha radice nelle domande del presente.
Fornire a queste giovani donne gli strumenti per aprire il ventaglio delle domande a misura di un’esistenza in cui siano aperte più possibilità di quante noi stesse ne possiamo vedere.
Sapere che, lì dove noi abbiamo aperto interrogativi, la risposta potrà essere per loro una tranquilla meta, nella concretezza del cammino che potranno percorrere iniziandolo alla fine del nostro.
Nel frattempo, nella quasi totale censura che ancora passa nella scuola sulla cultura delle donne, per le mie alunne ogni informazione ha la forza di una sorta di rivelazione che le colloca in un mondo che per un attimo le smarrisce con la mobilità dei suoi orizzonti.
E per restare all’altro fondamentale elemento della cittadinanza, che è il diritto all’integrità fisica, la vicenda della legge contro la violenza sessuale rivela in modo inequivocabile il fondamento sessista del patto sociale che ancora non riesce a fare i conti con l’ingombro del corpo femminile.
La legge, che sono abituati a studiare nella certezza e neutralità delle norme, rivela così, insieme alle ambiguità del presente, quella storicità delle “certezze” che consente di pensarsi come soggetti politici, uomini e donne che nell’accesso al patto sociale sono in grado di ripensarne i contenuti.
Sono strade faticose quelle che propongo, perché vanno nella direzione esattamente opposta rispetto a quella smemoratezza che la nostra società propone, offrendo il presente come luogo in cui la sovrabbondanza dei consumi è la risposta totalizzante, finale e finalistica insieme.
E la smemoratezza della scuola, che rimuove, come dicevo, prima di tutto il quotidiano, nei suoi gesti più semplici di gestione degli spazi, dei tempi, delle relazioni, finisce col richiedermi quel maternage che, nemmeno riconosciuto come tale, riproduce le condizioni di un lavoro affidato al tradizionale gratuito obbligatorio delle donne.
A chi si rivolgono le circolari ministeriali sullo “star bene” a scuola, in assenza di una riforma?
E che cosa significa interrogarsi sull’identità in un luogo in cui gli adulti deputati alla trasmissione del sapere sono prevalentemente donne mentre nei luoghi dove il sapere viene “elabora¬to” prevalgono gli uomini ?
E’ davvero così ininfluente l’essere donne o uomini nella gestione dei processi di formazione di quelli che saranno donne e uomini futuri ?
Domande che lascio aperte come una provocazione che mi coinvolge in prima persona, spazio inquietante da percorrere ogni giorno districandone con pazienza i significati più accessibili per le ragazze e i ragazzi che ogni anno mi ritrovo in classe.
Perché non è semplice proporre un’assunzione di responsabilità che vada ben oltre le banalità di quel conformismo dei gesti che ci si limita a richiedere a scuola.
Imparare che si è donne e uomini non in astratto, ma nella tangibile concretezza di un corpo segnato dalla propria storia a partire da quella nascita che ti colloca in una famiglia, in un territorio, in una cultura, in una fede, in una razza, in un sesso…per scoprire che non sempre l’incrocio delle casualità ti deposita dentro una condizione “pari”.
In-segno passo dopo passo, sul sottile crinale che divide la facile presunzione delle certezze, dalla fatica con cui ogni sapere si confronta inevitabilmente con la mia storia, cercando di costruire uno spazio in cui conoscere significhi anche prati¬care la memoria di sé come fondamento di una soggettività che impara ad attraversare con le proprie domande i luoghi della politica, per abitare la polis come cittadini e cittadine non come oggetti smarriti offerti a qualsiasi significato.
Diamo inizio ai lavori della prima giornata che ha per titolo appunto “I corpi in scatola”; coordinerà la prof. Rosangela Pesenti
Vorrei ringraziare, prima di tutto, a nome del Gruppo nazionale di Scienza della Vita Quotidiana per i discorsi che mi hanno preceduta perché ci hanno dato il senso di come Ferrara rappresenti per noi un contenitore affettuoso.
Ho ascoltato con piacere perché non mi sono sembrate parole formali, ma l’espressione di un interesse e un’attenzione reali per ciò che si muove nel mondo delle donne.
Tra le altre, infatti, una parola significativa è stata pronunciata con grande naturalezza: “femminismo” e voglio sottolinearlo perché rappresenta uno di quei termini che oggi qualcuno vorrebbe accantonare o rimuovere o deformare e averla nominata con questa tranquilla certezza non può essere che frutto di un sapere fatto di giorni vissuti insieme, da uomini e donne che hanno condiviso in questa città una presenza attiva su ogni problema, costruendo, anche attraverso incontri e scontri, momenti non sempre facili, ma nel reciproco riconoscimento, quel contenitore affettuoso che noi viviamo, in questo momento, in questa città.
Cominciamo da oggi a parlare della scuola smemorata: una scuola smemorata prima di tutto dei corpi delle donne, ma smemorata anche di sé, se tutta la complessa organizzazione del lavoro scolastico si regge sulla fantasia di un sapere che, elaborato altrove, nella scuola viene semplicemente trasmesso.
Nella scuola così non si conserva la memoria di quel quotidiano lavoro di ricerca che intreccia i saperi nelle storie e nei vissuti delle persone, insegnanti, alunne, alunni.
Questo “sapere” che, non dimentichiamolo, è prima di tutto un verbo, ci viene prevalentemente presentato come un “dato” che con le sue immobili certezze contribuisce proprio a rimuovere quel processo che le insegnanti (perché si tratta prevalentemente di donne) costruiscono giorno dopo giorno con le loro esperienze.
Così una professione in cui è massiccia la presenza femminile contribuisce ad una cancellazione delle donne in una occasione specifica del loro “fare”.
Per questo oggi vogliamo guardare al “contenitore” scuola e misurarlo con tre aspetti “contenuti”.
Un contenitore che è insieme materiale e simbolico, fatto di leggi, ordinamenti ma anche di luoghi fisici, disegnati dentro il tracciato urbanistico delle città così come nella nostra mente, luoghi che sovrappongono alla materialità dei nostri corpi, un sapere, un ordine del mondo, nel quale le donne sono cancellate o impreviste.
E dentro questo contenitore un corpo estraneo, il nostro, che si muove tra architetture visibili e invisibili, soggetto comunque di una storia anche in assenza di una storiografia che la registri.
Le donne che sono qui oggi per avviare il percorso di questo seminario non sono importanti solo per una loro autorevolezza disciplinare; Lidia Menapace, Ida Farè, Emma Baeri sono per noi anche una parte di quella storia comune delle donne che ha saputo interrogare i saperi a partire da sé, simboli affettuosi e materiali di un incrocio fecondo fra cultura, scuola e luoghi del femminismo.
Un intreccio che ha segnato le nostre storie e ci ricorda che dentro la rete delle relazioni che le donne hanno saputo costrui¬re il sapere è quell’evento che ci attraversa, prima di diventare il deposito fecondo che i nostri corpi agiscono nella storia.
“LA SCUOLA SMEMORATA” Ferrara 19.20.21.febbraio 1993
Il sole, ordinato a nostra insaputa dall’Udi di Ferrara e messo lì per stupire le siciliane con quella cortesia che la città conosce per lunga tradizione, se n’è andato, credo, un attimo dopo di noi.
E’ con qualche imbarazzo e con uno sguardo molto parziale che mi accingo a ripensare, rileggere, perfino giudicare le giornate di Ferrara e lo traduco, questo sguardo, in scrittura non solo perchè ritengo necessario dare visibilità a un “evento” (tale proprio perché si gioca tra previsione e sorpresa, tra gratuità e fatica) ma anche per un momento di generosità verso me stessa che di queste giornate appena trascorse ho vissuto soprattutto l’ansia della responsabilità che, come sappiamo, non diminuisce neppure se condivisa e perfino nella generale soddisfazione e nel visibile successo continua a ingigantire le più piccole crepe, gli inevitabili imprevisti, a rimuginare su perfezionamenti proponibili già per un prossimo appuntamento.
Perchè a questo ho subito pensato, che abbiamo bisogno di appuntamenti, sapere che esistono luoghi di scambio in cui è possibile una parola multiforme, che siano frequentabili non solo per l’autorevolezza dei discorsi ma anche per il piacere e l’intelligenza delle chiacchiere.
Intelligenza del reale, intreccio, scambio tra sguardi e storie diverse che trovano parole non necessariamente comuni ma comunicabili, relazioni inedite tra parole e percorsi: folla di pensieri, proposte, progetti, interrogativi e soprattutto una folla di volti, corpi, sguardi, mani, abbracci, sorrisi, richieste precise e vaghe, fluttuare di parole e serietà di ascolti, diffidenza e abbandono, perplessità e gioia, coscienza politica mi verrebbe da dire, e femminista, con l’orgoglio di un’appartenenza che m’interroga appunto su nuovi luoghi, spazi, appuntamenti in cui dipanare e tessere i fili multicolori che lì a Ferrara si sono intrecciati.
Ma forse dovrei dire con ordine dall’inizio, dalla solennità dell’aula magna dell’Università in cui abbiamo aperto i lavori con i saluti delle autorità, il Provveditore agli studi, gli assessori alla P.I. del Comune e della Provincia, il prof. Miegge per il Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia,che hanno voluto portare una presenza non formale ma attenta e interessata, un riconoscimento intellettuale e politico che non è mai scivolato nel paternalismo esprimendo al meglio la consapevolezza dei propri compiti.
Non una generica disponibilità ma la scelta di rispondere, di misurarsi prima di tutto con un soggetto politico complesso le cui istanze culturali, nello specifico, interrogano l’istituzione a partire dalla sua fondazione stessa; un soggetto politico conosciuto anche nella sua concreta presenza sul territorio che ha trovato nell’Udi una delle forme di espressione di sé certamente non marginali e ininfluenti nella città.
Testimonianza di una collaborazione insieme affettuosa e curiosa quella che ha espresso l’università, oltre che con le parole del prof. Miegge, con la presenza di Laura Balbo alla quale non premetto il “prof.” perché “è una di noi” e vicine abbiamo sentito le sue parole di “madrina” discreta che ha colto profondamente il senso della nostra dedica a Natalia Ginzburg.
Il tema della prima giornata “I corpi in scatola. La scuola come contenitore materiale e simbolico” ha affrontato attraverso le relazioni di Lidia Menapace, Ida Faré e Emma Baeri la scuola come luogo smemorato delle donne, indifferente ai loro corpi, alla loro storia, ai segni che pure lasciano e hanno lasciato sul mondo in quella quotidiana gestione di risorse e relazioni che riproduce per tutte e tutti il sapere della sopravvivenza.
Una scuola che rimuovendo il corpo femminile non trova fondamento a quella riproduzione sociale alla quale è istituzionalmente deputata perchè continua a confondere con modelli produttivistici quel lavoro della riproduzione che, dovremmo sapere come ovvio, riproduce differenze, a cominciare da quella sessuale e deve far crescere soggettività, non omogeneità.
Il corpo per la scuola è un ingombro, ha detto Lidia Menapace, perché intralcia quei programmi di misurazione oggettiva che contribuiscono ad una cancellazione/rimozione delle individualità
che ha voluto definire con una parola forte ma anche argomentata, genocidio delle intelligenze.
Dobbiamo dis-ordinare la scuola, come ha detto Emma Baeri cogliendo positivamente nel suo intenso intervento la provocazione che abbiamo voluto proporre mettendo a tema la scuola nella sua interezza chiedendo ad ognuna un contributo che, pur radicato nell’esperienza d’insegnamento, rompesse i confini disciplinari e gli ordini scolastici interrogandoli con la propria esperienza di donna.
Il mondo infatti viene prima delle discipline che sono le reti con cui cerchiamo di catturarlo e non è con corde usuali e su percorsi già perfettamente tracciati che si può muovere un soggetto così nuovo, e molteplice per definizione, come sono le donne.
Smemorata dei corpi e delle storie la scuola prevede archivi burocratici ma nessuna possibilità di ricordare a noi stesse le esperienze vissute che sfilacciano negli anni un tempo intenso e creativo utilizzato e svolto nel consumo quotidiano ma non considerato come patrimonio di ricerca sul campo.
Una ricerca che si è presentata subito nella ricchezza del dibattito con quella capacità che molte di noi hanno affinato, proprio nella pratica didattica, nel quotidiano confronto con allieve e allievi, di raccontare esperienze e ricavarne continue domande, a sé, alle altre, agli statuti epistemologici delle discipline che dobbiamo “trasmettere”.
Chiedere che la scuola trovi il suo modello nel domicilio e non nella caserma non significa aggiustare qualche mobile o qualche parete ma ripensare l’architettura invisibile, incrocio tra soggettività e tempo storico come dice Ida Faré, che disloca nello spazio quell’ordine del mondo come divisione fra un pubblico e un privato che le donne da tempo hanno messo “in discussione”.
Tema del secondo giorno: gli alfabeti, i linguaggi, i saperi riattraversabili con quella Scienza della vita quotidiana di cui dovremmo assumere consapevolmente la docenza e non fornirla a tutti i luoghi, a tutte le istituzioni sotto forma di quel maternage che gestisce le risorse trasgredendo i vincoli dati quel tanto che basta a garantire la sopravvivenza, a riprodurre vita, sapere , cultura senza mettere in discussione l’impianto generale che nella sua insensata inerzia ne fagocita ogni potenzialità creativa.
Solo la lettura degli atti potrà dar conto dei bellissimi interventi di Maria Bacchi sul “Sentimento del tempo: la memoria delle bambine” e di Carmen Plebani su “Salire al concreto: relazioni pericolose tra cose, concetti, corpi” e poi del lavoro del gruppo di insegnanti di Ferrara presentato da Marinella Antonelli e di quelle “Voci di donne in percorsi formativi extrascolastici” che Daniela Fuschini ci ha portato, testimonianza di un mondo femminile che la struttura attuale del mercato rende subalterno e che con grande dignità riesce a diventare protagonista della propria vita.
Anche i miei “Oggetti smarriti nella scuola media superiore” hanno contribuito ad affollare una giornata che pur prevedendo un tempo per i lavori di gruppo non ha avuto ore sufficienti per un dibattito della cui mancanza mi sono rammaricata al momento e oggi invece sento davvero possibile solo in tempi e modi più pazienti per la mole di riflessioni che a quel punto tutte le relazioni avevano messo sul piatto.
Non abbiamo fatto comunque indigestione passando, la sera, a quell’altro cibo, non metaforico, del teatro mangiabile di Maria e Marta Tacconi che hanno imbandito per noi il loro ironico, allegro e succulento alfabeto.
Ha cominciato Ansalda, da Ferrara, come d’ora in poi la chiameremo, mai abbastanza ringraziata, insieme a Liviana, Albertina e a tutte le compagne di questa città e di quest’Udi straordinaria, ha cominciato lei a cantare, con la sua bella voce padana e poi le catanesi e le toscane, lo stesso canto ironico e sfacciato nei diversi accenti, e Annarita senza voce e Lidia con le cadenze del Tirolo e perfino noi bergamasche nel nostro parco e incomprensibile dialetto e abbiamo anche ballato al suono delle nostre voci che hanno accenti, toni, pensieri diversi ma sanno rendere visibili i corpi, riconoscere le storie, comprendere le differenze e cancellare le gerarchie.
Il femminismo non si insegna a scuola, ne può essere la forza vitale come ci ha mostrato Zina Bianca, preside di una scuola media a Catania, domenica mattina, con la determinata passione dei suoi progetti e l’ironica, allegra, generosa testimonianza di sé.
Femminismo come storia, luogo d’origine in cui abbiamo giocato un sapere e un chiedere di noi stesse che è diventato quasi la sicurezza di un metodo, il coraggio di una non facile ricerca tra abbandono delle certezze, dei facili approdi, delle citazioni già confezionate e la voglia di trasmettere altri orizzonti alle giovani generazioni perchè i loro piedi possano camminare più sicuri e i loro pensieri più liberi.
L’inerzia fagocitante dell’istituzione universitaria ci è stata ricordata da Annarita Buttafuoco che ha ben argomentato la necessità che la ricerca delle donne possa permeare tutte le discipline universitarie favorendone rotture epistemologiche, contaminazioni, collaborazioni, percorsi inediti, perchè la novità politica del soggetto che noi siamo non rischi la via dell’emarginazione in una cattedra di “femminismo” che oggi forse volentieri ci darebbero per “accontentarci”.
Un discorso intenso in cui il nodo del rapporto tra istituzione e movimento, tra università e femminismo è stato espresso con chiarezza politica ma anche con il sentimento di una donna che riconosce ai luoghi delle donne quella “linfa vitale” a lei, come a noi tutte, necessaria.
Attenti e disponibili gli interventi di Paola Bottoni che sostituiva per la Regione Emilia-Romagna l’assessore Elsa Signorino e di Barbara Mapelli che sostituiva la Presidente delle commissione P.O. del M.P.I. Albertina Soliani, anche se la disponibilità personale non sempre è specchio di una reale capacità dell’istituzione di mettersi in sintonia con una proposta come la nostra che non prevede qualche taglio e aggiustamento ma interrogativi e mutamenti di forme e procedure prima e oltre che di contenuti.
Forse davvero dovremmo ricordare più spesso all’istituzione scuola che una “ricognizione dell’esistente”, un ascolto più attento e curioso, servirebbero ad evitare lo spreco e il degrado delle risorse (e nella scuola si tratta di risorse umane e soprattutto femminili guarda caso) o la costruzione di progetti vaghi ai quali poi saremo ancora noi a dare gambe con il solito abile e disconosciuto lavoro di “taglio e cucito”.
Ma partire dal quotidiano non è semplice operazione quantitativa richiede la messa in campo di categorie, concetti, parole che richiedono tempi e spazi di elaborazione, bisogna sapere insomma che, così come insegna la scienza, la stessa ricetta non dà mai lo stesso risotto.
E noi consideriamo “La scuola smemorata” un felice crocevia, un lieto evento, ha concluso Lidia Menapace col suo coraggioso mettere a tema una scienza della vita quotidiana che davvero disordina felicemente parole, ordini costituiti, gerarchie, tessendo nuove trame “come diciamo quando vogliamo fare paura” o proponendo pratiche rassicuranti, (ma non accomodanti) commestibili, frequentabili, pattuibili, rinnovabili, flessibili e così via…creativamente facendo.
Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere al Centro di documentazione delle insegnanti, nato per “gemmazione ” dal Gruppo nazionale Udi Scienza della vita quotidiana, col quale coabita a Roma al “Buon Pastore” Via della Lungara, 19.
Rosangela Pesenti
28.2.1993
